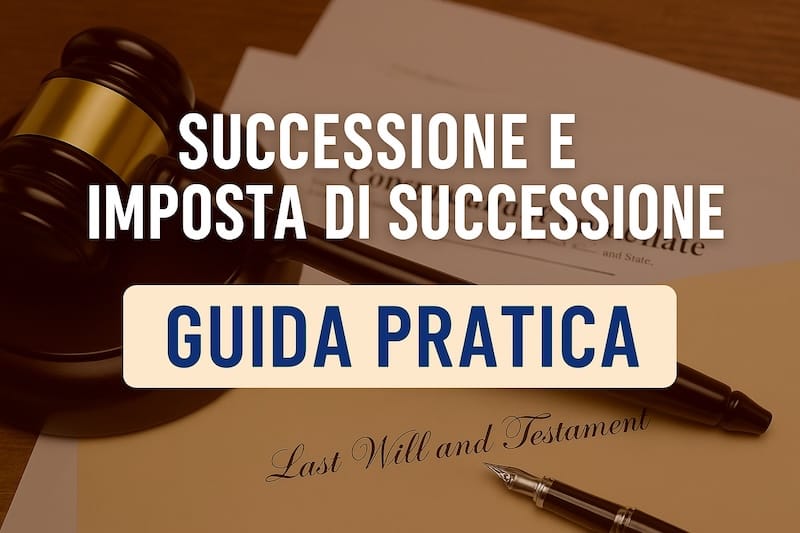La legge 5 febbraio 1992 n. 104, a tutti famosa come “legge 104” è una normativa italiana che si focalizza sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti persone con disabilità.
La legge 104/1992 è stato un provvedimento in controtendenza con il momento “storico” del “basta con lo stato sociale”, ma armonicamente avanzata, ponendo l’Italia, almeno sotto l’aspetto normativo, all’avanguardia in Europa, costituendo la “carta dei diritti dell’invalido”.
La finalità che ci si prefigge di raggiungere è l’integrazione sociale della “persona con disabilità”, la sua massima autonomia e partecipazione alla vita collettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti.
La norma afferma principi di equità molto elevati, in particolare quando stabilisce il diritto alle prestazioni in relazione al bisogno del soggetto, alla residua capacità ed all’efficacia della riabilitazione. e principi di solidarietà, quando determina la priorità degli interventi dei programma pubblici in favore dei casi gravi, ove le necessità di assistenza siano permanenti, continuative e globali.
Dunque, la legge 104 ha le seguenti finalità:
- rispetto della dignità umana e tutela dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata;
- integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;
- garanzia dei servizi e delle prestazioni necessarie per prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da handicap;
- previsione di interventi volti a superare l’emarginazione e l’esclusione sociale della persona disabile.
In questa ottica, oltre alle legge 104 del 1992, anche il Dlgs n. 151 del 2001, è di valido supporto ai familiari che assistono i familiari con disabilità grave, sia con i permessi sia con il congedo straordinario, che consentono ai caregiver di prendersi cura dei propri cari assentandosi per lungo tempo senza perdere il posto di lavoro e mantenendo la retribuzione.
Secondo la legge italiana, si definisce caregiver familiare:
” persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare di un affine entro il secondo grado, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. “
In base alla condizione di disabilità, il portatore di handicap ha diritto ai benefici riconosciuti in suo favore, in relazione al tipo di disabilità ed alle proprie capacità complessive. A seconda del tipo di handicap, si può avere diritto, ad esempio:
- a dei permessi retribuiti dal lavoro, i cosiddetti permessi 104: si tratta del diritto dei disabili e dei loro parenti più stretti di assentarsi dal lavoro mantenendo la retribuzione; la spettanza dei permessi 104 dipende da una serie di variabili e per poterli ottenere occorre seguire una specifica procedura;
- all’insegnante di sostegno nelle scuole;
- alle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei presidi medici (carrozzine, auto per i disabili, etc);
- ad un’agevolazione per l’acquisto di veicoli specifici;
- ad un’agevolazione fiscale per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Le disabilità possono poi essere suddivise in quattro categorie fondamentali:
- disabilità sensoriali: sono disabilità che riguardano i sensi (vista, udito, ma anche tatto, gusto, olfatto);
- disabilità motorie: riguardano la mobilità e l’efficienza degli organi delle parti del corpo deputati al movimento;
- disabilità intellettive;
- disabilità psichiche: riguardano i problemi psichici e relazionali (psicosi) e i problemi psicologici (nevrosi gravi e invalidanti)
Dunque la legge 104 del 1992 tutela i diritti delle persone con disabilità e loro familiari, prevedendo permessi retribuiti e congedi straordinari per assisterli. Il congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992 è un diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave.
Questo congedo consente di ottenere un periodo di assenza retribuita dal lavoro per prendersi cura del familiare in condizioni di gravità, come certificato dalla Commissione Medica Integrata. Il congedo straordinario può essere richiesto per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, anche frazionato, e viene concesso con un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, comprensiva di contributi figurativi.
I familiari che hanno diritto ai permessi retribuiti, sono:
- i genitori;
- il coniuge, o il partner dell’unione civile, o il convivente more uxorio: si tratta del convivente di fatto, come risultante dalla dichiarazione anagrafica (non è necessaria la firma di un patto di convivenza);
- i parenti e affini entro il 2° grado;
- i parenti e affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge/ la parte dell’unione civile/ il convivente del disabile hanno compiuto i 65 anni, oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, o sono deceduti o mancanti.
Il diritto ai permessi retribuiti può essere concesso (purché si provino, in concreto, le specifiche esigenze di assistenza) al familiare anche se:
- nel nucleo familiare del disabile si trovano familiari conviventi non lavoratori idonei a prestare assistenza;
- sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata(ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “no profit” e al personale badante).
Invece, i familiari che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito, sono:-
- il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente /il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
I due anni di congedo straordinario sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente, nell’intero arco della vita lavorativa. Pertanto, se vi sono più familiari per i quali si possa fruire del congedo, in ogni caso non è possibile superare i due anni totali, comprensivi di tutte le assenze inerenti ogni assistito.
Nel computo del limite dei 2 anni rientrano anche le giornate festive e non lavorative ricomprese tra le giornate di assenza.
Per poter accedere al congedo straordinario Legge 104, è necessario che il familiare assistito sia stato riconosciuto in stato di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 e non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Il congedo straordinario ha una durata massima complessiva di due anni (730 giorni) nell’arco della vita lavorativa del dipendente, fruibili anche in maniera frazionata. Nel senso che può essere suddiviso in giorni interi (ma non frazionato in ore). Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L’indennità per il congedo straordinario è calcolata sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (articolo 42, comma 5-ter, del Dlsg 51/2001). L’importo è soggetto a un limite massimo annuale, rivalutato annualmente dall’INPS.
L’importo massimo per il 2025 è pari a € 3.827,03 lordi al mese (€ 57.038 l’anno per 13 mensilità, comprensivo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), che corrisponde a € 125,80 al giorno.
Walter Recinella